II titolo è rubato al romanzo di Alfred De Musset indiscusso esperto di coma. Si nana di George Sand, che a Venezia l’aveva fatto becco con l’avvenente e curativo medico Pagello. In che conto si tenevano le coma lungo l’arco del novecento appena trascorso? Criterio quanto un altro illuminante, per chi si volga indietro dal varcato duemila.
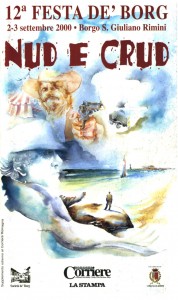 Anni novecentotrenta e quaranta. I treni del fine settimana riconducevano alle nostre rive ed alle consorti rimaste ai bagni di mare i mariti, tornati in città per lavoro. Convogli lodati nella pubblica opinione come “treni dei becchi”.
Anni novecentotrenta e quaranta. I treni del fine settimana riconducevano alle nostre rive ed alle consorti rimaste ai bagni di mare i mariti, tornati in città per lavoro. Convogli lodati nella pubblica opinione come “treni dei becchi”.
Notate la pastorale nomenclatura. I becchi eran fatti becchi (mariti della capra) dai bivi, (mariti della pecora). Infatti così si chiamavano in gergo (in italiano montoni) i ragazzi rivieraschi prodiganti affet-tuosità. La campagna, sconfitta nel suo tener campo come principale fonte di reddito, prestava ancora, ultima risorsa, i cornuti simboli araldici ad altre battaglie combattute in altri campi.
Il nomignolo di birro conquistò diritto al risperto patriottico. I bivi, credendo di servirsi, ma in realtà al servizio della nuova donna, fornivano a quanto pare, motivi d’ottima reputazione nel tam¬tam femminile di nostrane e forestiere. Benemeriti pionieri della ancor oggi perdurante fortuna della stagione, peraltro legata ad altre e meno arcadiche iniziative d’ospitalità.
II novecento fu per Rimini la scoperta della spiaggia. Fino allora, la marina era dispregiativamente definita come “I Sabbioni” e tra la città e il mare s’estendevano, dove ora è l’aristocratico viale Principe Amedeo, le paludi pascolo di somari che rosicchiavano cardi.
Si strinse, per inevitabile coincidenza, una alleanza Ira la donna che si spoglia ed il quattrino che circola: si creò il miracolo della colonizzazione dei “sabbioni”, comparve il Grand Hotel, il tram a cavalli che da Piazza Cavour arrivava a Marina Centro, e poi fino a Riccione provocando il fallimento dell’impresario Lardelli.
Un primo grafico per chi consideri il secolo che abbiamo alle spalle, dovrebbe illustrare la caduta ver-ticale dei mutandoni imposti alle donne. Prima, al gentil sesso niente bagno in mare. La tinozza. Poi le prime timide apparizioni al mare, ma direttamente dallo stabilimento aiutate da corde alle quali afferrarsi nel cimento del bagno, e le mutande alle caviglie. I guardoni si appostavano – racconta Italo Roberti – per sorprenderle all’uscita dell’acqua, con i camicioni bagnati e appiccicati, che rivelavano appetitose rotondità. Drastiche divisioni imposte tra maschi e femmine alla spiaggia con severissimi castighi a chi osava avventurarsi nei ginecei, o luoghi esclusivi del femminile.
In pochi anni, tutto sparisce. II guaio è – lo rilevava Alfredo Panzini – che per la donna, il nudo è potere, e anche se in autunno si rivestiva, nella femminile testolina restava nuda, ormai comandava molto di più che nell’estate scorsa, e molto più avrebbe comandato nella prossima.
Insomma, più di ieri e meno di domani.
Nei primi trent’anni, il fenomeno del mare fu d’élite. Poi, con i treni popolari e l’Opera Nazionale Dopolavoro, anche il mare fu messo in camicia nera, e in camicia nera s’affermò la partecipazione di massa. II comune senso del pudore combattè inutili battaglie di retroguardia, con il conforto di zelanti pulpiti che profetavano per chi osasse il nudo, castighi divini di tubercolosi ed asme.
Alberto Miliani, olimpionico di pugilato negli anni dell’immediato dopoguerra, racconta che il suo allenatore americano usava ancora a quei tempi e in Italia, un parascandalo: elegante pezza rettangolare, tesa sopra 10 slip da due cordoncini, per attenuare l’impatto delle protuberanze maschili. Le prime cicliste provocarono degli scandalizzati “oh!” di sorpresa, come anche il poeta Giorgio Caproni, riferisce divertito: “E quando s’era mai vista: a Livorno, una ciclista?” “Da noi, lungo Via Garibaldi” raccontò l’interessata al violinista e caricaturista Italo Roberti “i ragazzi si buttavano in terra, pur di vedere un pezzetto di stinco. Le mamme proibivano alle figlie di rivolgere la parola a quella spudorata che andava in bicicletta a far vedere tutto”.
Ferruccio Mandolesi era un bicicletta: arrampicato su quel velocipede con la ruota grandissima davanti e piccolissima dietro, che per fermarsi bisognava appoggiare il piede al davanzale delle finestre a pianterreno. Racconta il figlio Massimo: “Mio padre aveva una amorosa a Fano, e raggiungeva l’amata con il biciclo: pedali fissi sull’enorme ruota davanti. Non dimenticate che all’epoca le strade erano bianche e polverose. Fino a Cattolica, tutto abbastanza regolare. Ma arrivati in cima alla Siligata, c’era, una discesa molto più ripida e pericolosa di quella d’ora: il biciclo non aveva freni adeguati, e c’era il pericolo di rovesciarsi in avanti. Allora, un ingegnoso carbonaio, pensò di noleggiare fascine per la discesa. Legava una fascina alla canna del biciclo, proprio sopra la rotellina dietro, ed il coraggioso pedalatore, pagato il noleggio della fascina, si lanciava trascinando quella zavorra per la discesa, alzando nuvole di polvere. Arrivato alla fine, riconsegnava corda e fascina ad un ragazzo della ditta, e via dall’amata a Fano”.
Per il duemiladue ho proposto ad un ben disposto Ghirardelli per la Festa del Borgo, la rassegna degli album di famiglia riminesi, partendo proprio dai tre interlocutori citati.
Con l’avvento della televisione, è irrimediabilmente finito il tempo degli scherzi atroci. Prima li ha spodestati “Lascia o raddoppia”, oggi c’è il karaoke. Una volta si beveva, ed all’ubriaco proprio cotto si murava alla svelta la porta, alzandole davanti un muro di mattoni. Poi una passata di polvere, ed era tutto muro. Ancora in cattura della sbornia, il malcapitato si riduceva a casa per sette sentieri, e la porta era sparita. Brandendo l’inutile chiave, domandava al primo passante: “Avete visto la mia porta?”
Ancora più fantasiosa. C’era chi si prendeva la briga di trovare in un’altra città, una prospettiva simile a una familiare di Rimini. Ubriacata a dovere la vittima si caricava in auto, mentre dormiva l’innocenza, e si lasciava nel luogo somigliante a un’altra città di mare: Ancona, Ravenna. Sveglio, ma ancora viaggiando in nebbia, sicuro d’essere a Rimini, entrava nel solito bar che non era il solito, e domandava: “Avete cambiato barista?”
Questo per limitarci alla piccola cronaca: che se volessimo alzare il tiro, potreste riflettere sulla fine della civiltà del lavoro muscolare e sull’inizio della civiltà delle macchine: passaggio colto da Tonino Guerra nella poesia i bu:
Аndé a di icsé Ti bu chi vaga veia che quel ch ja fat, ja fat che adess us era prima se tratour e pienz e cor ma tott, anca mu me a di chic lavuré dal mieri d’an e adess ia d’andé veia a testa basa dri ma la corda longa de mazèl
Poi, e siamo alla fine, c’è proprio la storia della fine.
Quando è finito il novecento? L’opttocento si prolungò fino alla grande guerra del 1914. Il novecento rischiò la fine ad Hiroshima con la prima atomica, ma venne poco dopo decapitato dalle nuove tecnologie e da Internet. I nostri voti augurali ai nuovi cornuti che navigano in rete.
Benedetto Benedetti
